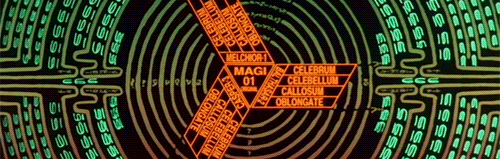Lo abbiamo atteso, lo abbiamo visto, lo abbiamo vissuto.
Un divario di trentacinque lunghi anni: 1982-2017.
Ed ora inizia lo spoiler, se non lo avete visto.
Ma in tal caso lo spoiler ve lo sareste meritato…
Il tutto e’ sciapo, ma in senso quasi positivo, un poco come lo e’ la vita vera che e’ monotona, grigia, sporca, inquinata.
Ma dove trovi sprazzi di gioia e sopratuttto amore nei posti o luoghi piu’ improbabili, che siano dentro o fuori di te, fin’anche fosse un’intelligenza artificiale, peraltro venduta a stock dalla medesima multinazionale che ti ha creato.
Si sei un cacciatore di androidi, e sei un androide. Lo si capisce dalle prime scene (dove troviamo un Bautista che assurge ad alte vette di recitazione, realmente. Fra micro-espressioni facciali, occhialetti, un infinitesimo accenno di barba. Quel poco per catalizzare, catturare)
Disilluso? No. Melanconico? Neppure.
Era il novembre del 2019. Il cacciatore di replicanti Rick Deckard (Harrison Ford) e Rachael (Sean Young) provano a fuggire da un destino segnato.
Ma nel “presente” 2049, i Nexus 8 sono stati da tempo superati dai replicanti Nexus 9, migliorati e perfezionati, resi più docili e obbedienti.
L’agente K (Ryan Gosling) assegnato alla Polizia di Los Angeles, e’ anche lui un “blade runner” incaricato di ritirare i modelli precedenti che ancora si nascondono da qualche parte.
Durante un ritiro scopre inavvertitamente un segreto sepolto da tempo, un segreto che potrebbe far precipitare nel caos quello che è rimasto della fragile società. E’ questa scoperta che lo portera’ alla ricerca di Deckard, sparito nel nulla da ormai 30 anni.
“Nato e non creato”. Con questo presupposto Denis Villeneuve costruisce impalcature visive e inquietudini filosofiche provando a replicare – senza soluzione di continuità – le derive sci-fi e noir che Ridley Scott era stato capace di toccare, ormai 35 anni fa, traducendo filmicamente Il cacciatore di androidi di Philip K. Dick nel primo Blade Runner.
Operazione forse impossibile da ipotizzare, che il grande schermo però riesce a restituire a tratti in maniera magniloquente. La fotografia di Roger Deakins (che, potete scommetterci, otterrà la 14° nomination agli Oscar, chissà se stavolta si degneranno di premiarlo…), le scenografie di Dennis Gassner, le musiche di Hans Zimmer e Benjamin Wallfisch, volutamente riecheggianti il Vangelis touch sono calzanti anche se i bassi sono al limite del surreale, cercando una quarta dimensione che sebbene dia profondita’, al contempo rischia di distrarre in alcuni momenti e diventa micro-cacofonia in altri. Insomma, nel bene o nel male , negli eccessi mancanti o troppo presenti, ogni elemento strutturale di Blade Runner 2049, non semplicemente “copia” dove puo’ l’originale, ma desidera il prolungamento (non un omaggio, anche se apre palsemente ad un possibile altro sequel) di un universo, visivo, ambientale, cinematografico, di uno tra i film più iconici della storia della settima arte con una visione della scienza che – ancora oggi e, soprattutto, con l’avvento di tecnologie forse impensabili ai tempi del primo film – continua a domandarsi “che cosa definisce un essere umano?”.
E qui il regista non si fa prendere da paure di sorta, sonda l’abisso della natura etica e bioetica, costruisce (nel vero senso della parola, visto che ogni set è analogico e non ricreato con il green screen) architetture in grado di ospitare comodamente lo script di Hampton Fancher e Michael Green, e instrada la prosecuzione di una storia iniziata 30 anni fa insinuando il dubbio laddove invece le creazioni di Niander Wallace (il nuovo “master of puppets”, ovvero Jared Leto, ndr) non dovrebbero prevederlo: dove finisce il confine tra l’obbedienza androide e la ricostruzione di un’identità creata dal nulla ma settata con l’innesto di ricordi artificiali? E che cosa succede se uno di quei ricordi è un frammento di memoria reale? Ci addentriamo in uno sconosciuto che sa di futuribile. Oggi, nel 2017, questo e’ sempre piu’ vicino. Abbiamo avuto il primo trapianto di testa in Russia, il primo chip neurale per una violinista con i tremori derivati dall’Alzaimer installato mentre suonava per vedere le risposte in tempo reale dei neuroni (operazione eseguita lo scorso anno in Israele), oppure le bambole erotiche con migliaia di sensori diversi ed un’intelligenza artificiale in continuo che viene cresciuta con ricordi e le caratteristiche della persona con cui vivra’ , ha uno scheletro antropomorfo e robotico con centinaia di attuatori e pelle sintetica. Uno degli usi che se ne vuole fare e’ per assisterre sessualmente e non i disabili. Apprende, cresce in interazione, elabora risposte a problemi, forse dopo tanto tempo e tanto codice sara’ viva in futuro? E cosa vuole dire viva?
Ci si muove lungo le traiettorie disegnate gia’ allora – la veduta area e notturna di una Los Angeles sempre più caotica e illuminata da ologrammi promettenti qualsivoglia svago e ristoro – e ridisegnate oggi attraverso una distopia ancor più grigia, figlia di un collasso degli ecosistemi avvenuto anni prima – l’enorme muro che difende la città dall’oceano minaccioso che vorrebbe mangiarsi altra terra, il freddo costante sotto la coltre, l’inospitalità di luoghi resi inabitabili dall’inquinamento dell’aria, la neve – ma, come era ovvio immaginare, il cuore della questione è ancora una volta nascosto nell’abisso di dilemmi ancora oggi irrisolvibili.
E l’unico, vero limite di Blade Runner 2049, forse, è proprio nel voler rendere più dirette, più a portata, più narrative, questioni che nel film precedente rimanevano sospese, mai enunciate apertamente, fuggendo da facili schematismi che, invece, stavolta, sembrano fiaccare il percorso del racconto, rischiando a volte di spogliarlo della poesia, dell’anima che – al contrario – tutto l’impianto visivo, visionario e architettonico (che raggiunge il suo apice quando la splendida Ana de Armas – l’ologramma Joi – si sovrappone al corpo della prostituta interpretata da Mackenzie Davis per rendere carnale, reale, il suo rapporto con K) riescono a mantenere vivo, saldo in quell’equilibrio quasi commovente tra ricordo del prototipo e creazione di un nuovo cult.
“Nato e non creato”, la questione è tutta lì: “In fondo non sei male, anche senz’anima”.